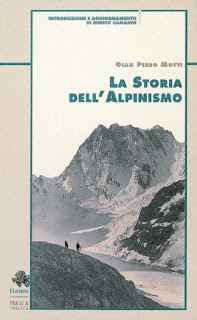La
trama dell’ultimo romanzo di Jonathan Franzen è tanto articolata e ricca di
colpi di scena, svolte rocambolesche e situazioni al limite dell’inverosimile
da poter essere paragonata a quella di un romanzo d’appendice o di una
telenovela.
Questo
può certo lasciare perplesso il lettore abituale di Franzen, ma non deve
tradursi automaticamente in un giudizio di disvalore, perché nel libro il
livello simbolico – sapientemente concepito e lucidamente integrato nella struttura
della vicenda e nel suo sviluppo – prevale sul tema narrativo puro e semplice;
praticamente, si può dire, fin dal titolo.
Purity
Tyler detta Pip è una ragazza di 24 anni che vive in California e lavora come
promotrice telefonica di progetti connessi con lo sviluppo delle energie
alternative. Lo stipendio che percepisce non le permetterà mai di ripianare il
pur modesto debito studentesco accumulato negli anni del college. La sua
famiglia è costituita unicamente dalla madre, commessa in un supermercato, una
nevrotica che nutre per la figlia un affetto soffocante, in un rapporto
esclusivo fatto di condizionamenti continui e sottili ricatti, essenzialmente
basato sull’azzardo morale, per usare l’espressione dell’autore.
Per
sfuggire per quanto possibile a questa situazione, Pip si è trasferita in una
casa occupata a Oakland, da cui presto la banca titolare dell’ipoteca sloggerà
i bizzarri squatter che la abitano.
Prima
che questo accada, però, in quella casa a Pip capita di incontrare un’attivista
tedesca di una organizzazione non governativa che predica e pratica l’utilizzo “piratesco”
della rete internet come mezzo per rendere assolutamente trasparente il
rapporto tra governanti e governati, tra i detentori del potere e il resto dei
cittadini.
La mission di questa Ong, il Sunlight Project, è quella di svelare,
grazie all’apporto di una nutrita squadra di hacker, informatori, infiltrati,
gli irraccontabili segreti dei potenti al vasto pubblico della rete; un po’
come fa Wikileaks.
Ma
se su Wikileaks si proiettano tutte
le ombre che si addensano intorno all’ambigua figura di Julian Assange, il
fondatore del Sunlight Project, l’ex
dissidente della DDR Andreas Wolf, appare realmente una sorta di cavaliere
senza macchia e senza paura.
L’attivista
tedesca, la bella Annagret, prende in simpatia Purity, in maniera apparentemente del
tutto casuale, e le propone uno stage lautamente retribuito
presso il quartier generale boliviano del Sunlight
Project.
Pip
dapprima rifiuta, ma una spiacevole disavventura sentimentale, le continue
difficoltà nel rapporto con la madre, il suo assoluto bisogno di soldi e,
soprattutto, l’intervento in prima persona del mitico Andreas Wolf la inducono
infine ad accettare.
A
questo punto l’intreccio si complica, e la gestione dei piani temporali della
storia diventa assai più dinamico e articolato: prima di conoscere quale sia
stata l’esperienza di Pip in Bolivia, veniamo a sapere molte cose sul passato
di Andreas Wolf nella Germania dell’Est, che contempla un’infanzia da bambino
prodigio − figlio di due notabili della classe dirigente socialista −, un’adolescenza
ribelle, dopo l’emersione di tutta la carica morbosa del legame ossessivo con
la madre psicotica, e una giovinezza da “spostato di lusso”, che la Stasi
protegge per via del peso politico dei due importanti genitori, ma che
custodisce anche un terribile inconfessabile segreto.
Jonathan Franzen
L’obiettivo
del narratore si sposta poi su Pip al lavoro a Denver, presso il quotidiano Denver Indipendent, mentre supporta il
direttore Tom e la sua fidata collaboratrice Leila (che è anche la sua amante e
praticamente la sua compagna) in un’inchiesta giornalistica sulla misteriosa
sparizione di una testata nucleare dai magazzini della fabbrica texana che
produce gli ordigni.
Leggiamo
infine il racconto-confessione di Tom sui suoi esordi giornalistici ai tempi
dell’università e sul suo tormentato amore con Anabel, la giovane erede della
mirabolante fortuna dei proprietari della McCaskill, colosso dell’industria
alimentare trasformatosi in una poderosa multinazionale dai molteplici
interessi finanziari.
Anabel,
bizzosa e lunatica, in realtà, è tutta compresa nella sua tensione ideale, è
prigioniera del suo moralismo e delle sue velleità da artista d’avanguardia, ed
è ossessionata dall’utopia di vivere una vita contraddistinta in tutto e per
tutto da una semplicità e da una purezza monacale: col matrimonio, costringerà
dunque Tom a rinunciare a tutti i soldi a cui avrebbe potuto avere accesso per
coltivare la follia di un legame modellato sulla stramberia e sulle
idiosincrasie della sua donna. Il divorzio sarà l’esito inevitabile di quel
matrimonio.
Solo
a questo punto il resoconto delle avventure di Pip in Bolivia, finalmente
proposto, consentirà di cominciare a riannodare i fili della narrazione,
permettendo al lettore di orientarsi meglio e delineando un panorama inopinato:
Pip altri non è che la figlia di Tom e Anabel, concepita all’insaputa del padre
proprio nei giorni della rottura definitiva fra i suoi genitori; la ragazza – a
dispetto della miseria economica in cui la madre, impegnata nella realizzazione
del suo ideale di povertà, l’ha sempre fatta vivere – è quindi erede di un
patrimonio calcolabile in miliardi di dollari.
Il
suo incontro con il padre naturale, ovviamente, non è stato casuale: esso è
stato perfidamente architettato da Andreas Wolf per mettere in difficoltà Tom
che, trovandosi in Germania per ragioni personali nei giorni convulsi della caduta del muro di Berlino, ha
raccolto per avventura la confessione da parte di un Andreas non ancora famoso del suo
terribile segreto, vale a dire l'efferato omicidio del patrigno di Annagret, compiuto
per difendere la ragazza, allora minorenne, dalle violenze dell’uomo, e rimasto impunito. Andreas è
ora ossessionato dalla prospettiva che quel segreto riemerga dalle nebbie del passato
sporcando la sua immagine pubblica; non essendo riuscito a far diventare Tom
suo complice grazie al fascino e all’abilità che chiunque gli riconosce, vuole
ora dimostrargli che possiede i mezzi per ricattarlo personalmente, incatenandolo a sé.
Il
finale del libro non sarà meno eclatante della storia per la quale è costruito.
Il
tema che sta alla base di questo articolatissimo intreccio è quello della
verità e della purezza morale alle quali ci si illude che si possa attingere
grazie alla capacità di Internet di conservare traccia dei nostri più riposti
segreti individuali, e di renderli disponibili direttamente a chiunque, senza filtro alcuno.
Ma per
Franzen lo statuto di realtà di ciò che appare in rete è di per sé precario, e ingannevole risulta la sua presunta evidenza ontologica. Verità e purezza sono infatti esattamente come la luce del sole: non si possono
osservare se non dotandosi di opportuni filtri, pena il rischio di esserne
accecati. E abolendo ogni confine tra pubblico e privato, tra trasparenza e invadenza, tra critica e molestia, tra cimento e tormento, tra denuncia e pettegolezzo, tra sfondo e primo piano, tra reale e virtuale non si presta un buon servizio alla verità; si rischia solo di distorcerla in maniera grottesca.
Le
problematiche toccate dal romanzo, come ognuno può capire, sono di un’attualità
assoluta e di una complessità straordinaria. Franzen cerca di trattarle con
profondità filosofica e sapienza letteraria (il concetto di inosservabilità del
vero in una società in cui tutto è declinato secondo le leggi dell' intrattenimento è già stato magistralmente tematizzato nella letteratura americana, in
anni da noi non lontanissimi, da David Foster Wallace, a cui certo l’autore del
libro deve aver pensato).
Nonostante
qualche eccessivo didascalismo − e il riflesso automatico, in alcuni giudizi
espressi (come quelli su Julian Assange, Bradley Manning o Edward Snowden), di
discutibili opinioni largamente diffuse negli Stati Uniti – il romanzo
è
molto interessante, anche se, nel suo complesso, non è forse all’altezza delle maggiori prove
narrative di Franzen.
Voto: 7,5