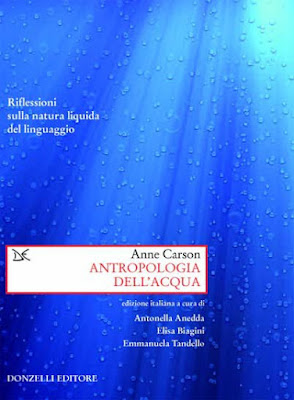I libri di Fabio Genovesi danno vita a uno stile letterario tutto particolare, che potremmo chiamare "realismo fiabesco": nell'ottica dell'autore, infatti, la realtà è intrinsecamente fiabesca. Ciò non significa che la visione espressa sia banalmente edulcorata, priva di articolazioni concettuali o di profondità; vuol dire invece che la vita e il mondo sono teatri dell'avventura e del mistero, dove il processo della conoscenza può compiersi autenticamente soltanto in una dimensione narrativa, emotiva e simbolica.
Questi sono i paradigmi entro cui si inscrive anche Il calamaro gigante. In questo testo, che non è propriamente un romanzo, e ha un andamento divagante e sussultorio, Genovesi mette in collegamento il proprio costante spiazzamento al cospetto di un'esistenza che non riusciamo mai a padroneggiare fino in fondo, che riserva sempre delle sorprese, che pare in larga parte inconoscibile e in cui il caso sembra avere un ruolo preponderante con la storia naturalistica della scoperta del calamaro gigante.
Il calamaro gigante popola le profondità degli oceani, luoghi da cui l'uomo è escluso, ma che pullulano di una vita che duriamo fatica a immaginare, e che procede da millenni indifferente alla nostra presenza sulla Terra. Per secoli, la scienza - nella sua sobria asciuttezza, che talvolta si trasforma in ottusa aridità - ha respinto come frutto di vaneggiamento qualsiasi tentativo di includere nel novero dei viventi quegli strani esseri che comparivano nei racconti spaventati dei marinai. I signori della conoscenza intellettuale di natura libresca tendevano a liquidare le narrazioni della gente di mare come pure leggende, prodotte dal distacco dalla civiltà, dall'abbrutimento, dall'alcol, dalla fantasia storpiata dalla solitudine.
Eppure c'erano coraggiosi esploratori e persino uomini di lettere capaci di ascoltare chi il mare lo viveva quotidianamente, che avevano raccolto testimonianze e prove giocoforza frammentarie che suggerivano come i resoconti dei fortuiti incontri dei marinai con colossali mostri marini difficili da classificare avessero un fondamento di verità.
Così, ad esempio, nel Seicento, un prete di Ravenna, don Francesco Negri, che a quarant'anni (età ragguardevole per l'epoca) si mette in viaggio dalla sua terra natale verso il grande nord e, di convento in convento, arriva fino alla terra dei Lapponi e al circolo polare artico per riportarne la prima descrizione del portentoso e terribile Kraken, "un pesce di smisurata grandezza, di figura piana, rotonda, con molte corna o braccia alle sue estremità...".
Così, nel Settecento, il norvegese Erik Pontoppidan, vescovo di Bergen, che nella sua Storia naturale della Norvegia, a rischio di essere giudicato un folle, include - sulla base dei racconti della gente della costa - "il più grande mostro marino del mondo", e per primo lo battezza calamaro.
Così Pierre Denys de Monfort il malacologo di Dunkerque che, alla fine del XVIII secolo, chiamato a completare l'imponente lavoro classificatorio di George Louis Leclerc de Buffon, si gioca tutta la sua credibilità scientifica azzardandosi a parlare - sulla base di una convinzione maturata negli anni - del polpo colossale e del polpo Kraken. Deriso e di fatto escluso dal mondo delle Accademie scientifiche dallo scetticismo dei colleghi, muore povero e solo di fame e di stenti a Parigi, nel 1820 o nel 1821.
Il problema è che, a un certo punto gli avvistamenti del calamaro gigante da parte delle imbarcazioni che solcano gli oceani si moltiplicano: particolarmente significativo, perché ben documentato, quello che nel novembre del 1861 vede protagonista la nave francese Alecton del capitano Bouyer, lungo la rotta atlantica verso la Guyana.
E, con il moltiplicarsi degli avvistamenti, arrivano anche le prime prove concrete: i resti di tentacoli lunghi anche 10 metri raccolti da alcune baleniere, e poi calamari giganti interi, spiaggiatisi sulle coste dell'isola di Terranova e in Nuova Zelanda fra il 1871 e il 1881.
E allora anche gli scettici devono ricredersi, arrendersi e ammettere che il calamaro gigante esiste; esiste, quasi a nostro dispetto, in abissi che ci sono preclusi, dove quotidianamente ingaggia una lotta per la sopravvivenza con il capodoglio, che se ne nutre e lo caccia, e a volte ne riporta ferite mortali.
Come nelle fiabe classiche, anche in questa documentatissima storia, naturalmente, c'è una morale: l'esistenza del calamaro gigante ci insegna che la natura non è al nostro servizio (come ci piace credere), che ne facciamo solo parte insieme a molte altre forme di vita, a volte lontanissime da noi, e la conosciamo meno di quanto pretendiamo di conoscerla - come ci raccontano le miriadi di errori di valutazione che l'uomo ha commesso nel corso della storia della scienza. Forse allora sarebbe il caso di rapportarci in maniera diversa con lei; perché, se la natura può esistere senza noi, noi non possiamo in nessun modo esistere al di fuori della natura.
In poche parole: i
libri di Fabio Genovesi danno vita a uno stile letterario tutto
particolare, che potremmo chiamare "realismo fiabesco": nell'ottica
dell'autore, infatti, la realtà è intrinsecamente fiabesca. Ciò non
significa che la visione espressa sia banalmente edulcorata, priva di
articolazioni concettuali o di profondità; vuol dire invece che la vita e
il mondo sono teatri dell'avventura e del mistero, dove il processo
della conoscenza può compiersi autenticamente soltanto in una dimensione
narrativa, emotiva e simbolica.
Questi sono i paradigmi entro cui si inscrive anche Il calamaro gigante.
In questo testo, che non è propriamente un romanzo e ha un andamento
divagante e sussultorio, Genovesi mette in collegamento il proprio
costante spiazzamento al cospetto di un'esistenza che non riusciamo mai a
padroneggiare fino in fondo, che riserva sempre delle sorprese, che
pare in larga parte inconoscibile e in cui il caso sembra avere un
ruolo preponderante con una leggenda trasformatasi in dato naturalistico: quella di cui ci parla la storia della scoperta del
calamaro gigante.
Voto: 7