Gian Piero Motti era davvero un
bel personaggio: nato a Torino nel 1946 (l’anno della morte di Giusto
Gervasutti, “il fortissimo”, colui che trasportò nelle Alpi occidentali la
perizia tecnica maturata nelle Dolomiti in anni di pratica dell’arrampicata
artificiale), alpinista di vaglia in prima persona (diede buona prova di sé
soprattutto sulle pareti della Valle dell’Orco), fu un uomo colto e dai
molteplici interessi. Oggi lo si ricorda soprattutto come l’animatore del Nuovo mattino, il movimento che portò nel
mondo chiuso dell’alpinismo molti degli stimoli derivanti dalla contestazione delle
istituzioni tradizionali fra gli anni sessanta e settanta, e ne favorì l’uscita
dalle secche di un’ideologia fondamentalmente reazionaria. Eternamente preda di
un’irriducibile inquietudine, Motti si tolse la vita nel 1983, ad appena 37
anni.
La sua Storia dell’alpinismo − pubblicata per la prima volta nel 1978 e
recentemente riproposta con l’aggiornamento di Enrico Camanni riguardante gli
sviluppi che questa disciplina ha conosciuto dopo quella data − è la seconda
Storia di ampio respiro dedicata all’alpinismo mai scritta, dopo quella dell’inglese
Claire-Eliane Engel, che però risale agli anni cinquanta del Novecento, parla
esclusivamente dell’attività svoltasi nelle Alpi, ed è afflitta da una
prospettiva smaccatamente “anglocentrica”.
Anche il ponderoso volume di
Motti (conta in tutto più di 700 pagine) risente naturalmente dei paradigmi
culturali dell’epoca in cui fu concepito; e tuttavia, al netto di alcune
considerazioni tecniche inevitabilmente datate, l’approccio dell’autore appare
ancor oggi perfettamente funzionale a un discorso sull’alpinismo coerente,
dotato di solide basi teoretiche, e nello stesso tempo capace di accogliere tutte
le suggestioni avventurose e di far risaltare il profilo di tutti i personaggi
straordinari che il racconto delle imprese alpinistiche da sempre porta con sé.
Il rapporto tra l’uomo e la montagna
è descritto sulla scorta di una visione della realtà che si vuole fondata
soprattutto sui principi della teoria psicanalitica, ma che si nutre anche
delle numerose e disparate letture di Gian Pietro Motti, in cui un ruolo di
primo piano hanno senz’altro riflessioni di ordine antropologico, filosofico e
sociologico.
Così l’autore considera come è
certamente vero che l’uomo cominciò a guardare alle montagne e a scalarle in
epoca illuministica − una volta venuti meno i tabù e le false credenze che lo
tenevano lontano dalle vette −, spinto principalmente da motivazioni di
carattere scientifico; ma sostiene altresì che presto il piacere della
scoperta, il brivido dell’avventura, il desiderio di conquista e il bisogno di
libertà soppiantarono la scienza. Quest’ultima divenne sovente una semplice
scusa per giustificare un’attività altrimenti priva di qualsiasi utilità
materiale, e perciò scandalosa agli occhi di quella società borghese da cui
provenivano i primi frequentatori delle montagne.
Un'immagine di Gian Piero Motti
Ci fu infatti un’epoca in cui l’alpinismo
fu appannaggio esclusivo dei cittadini benestanti; solo in seguito i “montanari”
– cacciatori di camosci o cercatori di cristalli inizialmente utilizzati come
semplici portatori o come “accompagnatori” da chi andava per monti (con un
ruolo subalterno o ancillare rispetto a quello dell’alpinista di turno) −
presero coscienza delle proprie capacità e, oltre a continuare a lavorare come
guide al servizio dei cittadini, cominciarono a esplicare in proprio un’attività
d’avanguardia di esplorazione delle cime e delle pareti dei rilievi fra i quali
vivevano.
Si dovrà comunque attendere la
fine della Grande guerra per vedere anche i ceti meno abbienti avvicinarsi
definitivamente alle montagne, quando l’alpinismo divenne per molti – che fossero
cittadini o valligiani – un mezzo di riscatto al cospetto delle miserie
quotidiane.
Solo a partire dal secondo
dopoguerra, infine, si assistette a una specializzazione e a una sorta di
professionalizzazione dell’attività alpinistica, dapprima con l’accesso al
mestiere di guida di praticanti provenienti da zone urbane non montagnose, poi,
in anni a noi più vicini, con l’avvento degli sponsor e (dagli anni settanta)
con la trasformazione dell’alpinismo in una disciplina sportiva tout court,
capace di suscitare perfino un grande interesse mediatico.
In questo quadro evolutivo, l’aspetto
più interessante del racconto di Motti è a mio parere l’articolata e
problematica ricerca di un criterio di valutazione omogeneo delle molte celebri
scalate effettuate in epoche diverse su terreni differenti da uomini che
potevano contare sul supporto tecnico di materiali all’inizio semplicissimi e
poi via via più sofisticati.
In sostanza, Motti ritiene in
fondo fallace ogni tentativo di classificare in maniera assolutamente oggettiva
le difficoltà incontrate dagli alpinisti che effettuarono quelle imprese,
perché “le vere difficoltà sono sempre di carattere psicologico”, e i primi
salitori di una parete si trovano sempre a dover abbattere una “barriera”
mentale con cui i ripetitori non dovranno più confrontarsi.
Questo non vuol dire che le
considerazioni prettamente tecniche vengano messe in secondo piano in questo
libro; anzi Motti, da alpinista esperto qual era, non manca mai di prestare un’adeguata
attenzione, oltre che alla filosofia che ispirò ciascuno scalatore, al suo
stile, alla sua “creatività”, alla sua abilità su rocce di diverso tipo e su
ghiaccio, alla capacità di servirsi in maniera adeguata degli strumenti che la
tecnologia della sua epoca gli metteva a disposizione.
In tal modo si riescono a
inquadrare nella maniera migliore e senza pregiudizi le imprese sia dei cultori
dell’arrampicata artificiale sia dei “puristi” difensori dell’arrampicata
libera, individuando in ciascun ambito coloro che seppero eccellere nel filone
che avevano scelto.
Trovano così il giusto risalto i
protagonisti delle diverse fasi dell’evoluzione della disciplina, che a volte
vengono presentati come veri e propri miti in pagine assolutamente memorabili:
da Coolidge a Whymper, da Georg Winkler a Tita Piaz (il celebre “diavolo delle
dolomiti”), dal mitico Mummery ad Angelo Dibona, da Dülfer a Preuss, da Emil
Solleder a Emilio Comici, da Gian Battista Vinatzer al grande Riccardo Cassin (“il
risolutore”). E poi Giusto Gervasutti ("il Michelangelo dell'alpinismo"), Pierre Allain, Gaston Rébuffat, l’insuperabile
Hermann Buhl, per arrivare fino a Walter Bonatti, a René Desmaison e a Reihold
Messner (senza dimenticare i molti “eroi sconosciuti” che Motti non manca mai
di richiamare).
La lettura è piacevole, coinvolgente, interessante sia per gli appassionati di alpinismo, sia per coloro che guardano a questa pratica solo dall'esterno, con la curiosità dei profani. Facile è immedesimarsi nelle avventure che Motti racconta, facile commuoversi di fronte a talune figure scolpite dalle sue parole, dal giro delle sue frasi non sempre del tutto precise, ma ogni volta estremamente efficaci.
Voto: 7,5

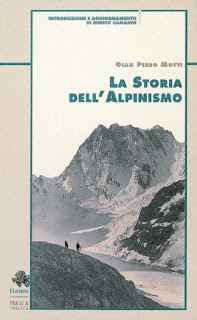

Nessun commento:
Posta un commento